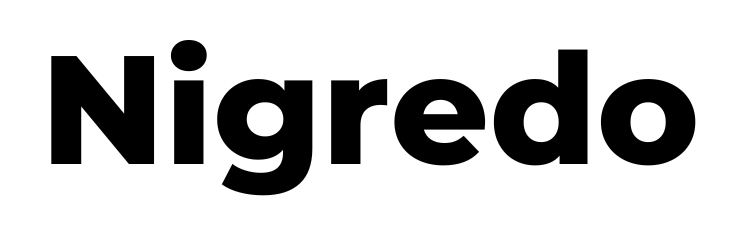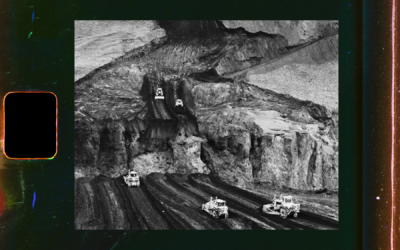Una testimonianza diretta che ci è arrivata a distanza di qualche mese dalla fine della battaglia per il Parco Don Bosco di Bologna.
Al parco Don Bosco abbiamo ottenuto una vittoria. Diciamolo subito, per non giocare la parte degli eterni insoddisfatti o, peggio, quella di chi ha bisogno di posizionarsi come perdente per sentirsi legittimato a portare un punto di vista. Diciamolo anche per disinnescare la retorica della “concessione” fatta dal Comune: ovvio che finché non si destituisce l’amministrazione di ogni potere, resterà sempre la concessione la forma che assumeranno i nostri passi avanti, soprattutto nelle parole del governo cittadino.
Ma la cosa davvero interessante allora è capire i rapporti di forze, le congiunture, le tecniche e le tattiche, che hanno spinto l’amministrazione a questo cambio di rotta (anche se su un progetto dal budget limitato rispetto al Passante di Mezzo o al Tram). Una vittoria, quindi. In una situazione molto particolare, specifica. Quali elementi hanno reso “forte” la lotta per salvare il parco Don Bosco? Che rapporto c’è stato tra il “movimento reale” del Don Bosco e la dialettica pubblica che ha preteso di riuscire a raccontare cosa stava succedendo? E ancora, questa situazione cosa ci dice del rapporto tra la rappresentazione delle resistenze, e il governo effettivo dei territori?
Proviamo una prima risposta, che poi svilupperemo: al Don Bosco l’installazione fisica del presidio ha innescato un processo che superava la dimensione politica, superava cioè le rivendicazioni portate per la legittimazione pubblica della lotta. Il discorso ecologista ha funzionato da “copertura retorica” di bisogni e desideri, ecosistemi affettivi, molto più complessi.
Allo stesso tempo, nessuna delle forze che hanno provato a rappresentare la lotta, cioè a parlare “a nome del parco”, ha mai avuto la capacità di controllare – tramite le retoriche ecologiste o altre retoriche “sociali” – lo sviluppo politico e umano del presidio e delle proteste. Quella che sembra una debolezza, si è rivelata la forza più grande: il discorso pubblico che aveva fornito la legittimazione per la “presa del parco”, non ha funzionato come meccanismo che inquadrasse le forme di vita del parco, né tantomeno le forme della protesta. Soprattutto, nessun “confronto” si è installato a partire dalla legittimità che il presidio aveva acquisito: un confronto del genere avrebbe solo potuto portare gli abitanti del parco a relativizzare le loro richieste di fronte a un rapporto dialettico smisurato. L’opacità verso l’amministrazione è stata la forza del parco.
Questo è stato evidente in particolare nei momenti di intervento violento delle forze dell’ordine, quando la piazza ha risposto in maniera disordinata e proprio per questo molto poco controllabile. In quei momenti (oltre che nelle giornate invernali in cui il presidio veniva effettivamente inventato dal nulla) si è osservata una fantasia coraggiosa. A cascata, questa situazione ha trasformato un piccolo progetto di parco in una situazione ingestibile.
Mettere radici in cima agli alberi
al Don Bosco l’installazione fisica del presidio ha innescato un processo che superava la dimensione politica, superava cioè le rivendicazioni portate per la legittimazione pubblica della lotta. Il discorso ecologista ha funzionato da “copertura retorica” di bisogni e desideri, ecosistemi affettivi, molto più complessi, contraddittori
Chi guardasse alla lotta del Don Bosco alla luce delle rivendicazioni pubbliche enunciate al parco («no al progetto Nuove Besta. Sì alla ristrutturazione delle vecchie scuole. Salvare il parco») rischierebbe di non capirci niente. In particolare, resterebbe cieco a una forza che non sprigiona da nessuna ragione, ma dall’alchimia improbabile di varie e testarde prese di posizione che hanno trovato la situazione per “impuntarsi” in un luogo.
Quello che ha giocato un ruolo fondamentale è stata la voglia di difendere il proprio parco, quello dove si porta a spasso il proprio cane; oppure la voglia di avere uno spazio comune che fosse accessibile in ogni momento; la voglia di difendere degli alberi con una tecnica costruttiva, fabbricando il proprio terreno di lotta; la voglia di avere un posto dove passare qualche notte senza pagare. La voglia di vivere in un posto almeno un po’ più bello del grigiore polveroso che assedia S. Donato. Anche il bisogno di un pasto in più, per alcuni.
Nessuno degli elementi elencati nell’ultimo paragrafo ha una sua propria “ragione” che sia pubblicamente giustificabile. La ragione è invece stata fornita da un discorso ecologista di critica al modello di rinnovazione urbana portato avanti dal PD e da questa giunta in particolare. Tutto vero, tutto giusto, ma limitandosi alla dialettica tra ecologia e sviluppo non si troverà una spiegazione di quello che è accaduto. Sono delle volontà particolari, che in passato o in altre situazioni avrebbero anche potuto essere tacciate di “egoismo”, che hanno dato sostanza alla situazione.
Queste volontà e forme di vita testarde sono un sottotesto inconfessabile di quei fenomeni che chiamiamo lotte. Spesso sono vissute come qualcosa di scabroso, da nascondere perché troppo collegato a un desiderio specifico, particolare. I “movimenti” creano allora un vocabolario “di lotta”, generalista, per spiegare in modo adeguato e consono quello che sta accadendo. Ma così facendo, non si recide proprio la parte più interessante del racconto? Non ci si preclude proprio la possibilità di capire in che modo un interesse particolare si riverberi oltre la cerchia che lo aveva concepito?
Proviamo a fare un po’ di inchiesta-a-posteriori, buttando lì alcuni spunti su questa realtà contingente di bisogni e desideri che hanno trovato spazio al don bosco
- si è visto minacciato uno spazio quotidiano, attorno al quale erano strutturate le abitudini di diverse persone. Abitudini collegate al relax e al tempo libero. In un quartiere che cambia a vista d’occhio, non si è trattato della prima volta.
- Questa minaccia ha assunto anche un carattere estetico. Il parco Don Bosco non è bello ma è un’isola di verde in un quartiere dove il cambiamento significa grigio, cemento, smog, cantieri, polveri. Prima di qualsiasi spiegazione tecnica, c’è stata una intuizione estetica: tante persone si sono accorte che preferivano il verde al grigio, preferivano la continuità lenta del parco al rinnovamento perpetuo fatto di cantieri
- Un’associazione di “anziani” del quartiere conosceva a menadito la vita del parco, le specie che lo abitano, il piccolo ecosistema su cui si affacciavano quei condomini dove si sono svolte le prime assemblee contro il progetto… una passione, un hobby, dunque, ma allo stesso tempo l’intenzione – per quanto naive e ingenua possa sembrare – di conoscere, prendere in mano in prima persona, il proprio ambiente.
- Non pochi giovani (del quartiere o di fuori dal quartiere) hanno trovato al parco uno spazio che era popolato a ogni ora, un posto dove potevi andare senza doverti dare appuntamento, senza un prezzo monetario o relazionale. Questa funzione di “luogo per l’incontro garantito”, in passato era svolta da spazi universitari o da alcuni “spazi sociali”. Dalla pandemia, questi luoghi sono scomparsi o comunque sono molti di meno.
- Alcune persone senza dimora hanno trovato al parco un riparo, un pasto garantito, un momento relazionale paritario.
Dietro la rappresentazione
Nessuna delle forze che hanno provato a rappresentare la lotta, cioè a parlare “a nome del parco”, ha mai avuto la capacità di controllare – tramite le retoriche ecologiste o altre retoriche “sociali” – lo sviluppo politico e umano del presidio e delle proteste. Quella che sembra una debolezza, si è rivelata la forza più grande: il discorso pubblico che aveva fornito la legittimazione per la “presa del parco”, non ha funzionato come meccanismo che inquadrasse le forme di vita del parco, né tantomeno le forme della protesta. Soprattutto, nessun “confronto” si è installato a partire dalla legittimità che il presidio aveva acquisito: un confronto del genere avrebbe solo potuto portare gli abitanti del parco a relativizzare le loro richieste di fronte a un rapporto dialettico smisurato. L’opacità verso l’amministrazione è stata invece la forza del parco.
Quel particolare gioco di voci e controvoci che comincia quando una lotta acquista energia, funziona in primo luogo per far circolare le informazioni sulla lotta, i claim di chi combatte, e gli appuntamenti della battaglia: cortei, manifestazioni, ritrovi, assemblee. Allo stesso tempo, il contrappunto ordinato tra parte e controparte, delimita la logica della vertenza, concentra lo sguardo attorno a pochi punti oggetto di dibattito, lasciandoci l’impressione che sarà la vittoria dialettica su questi punti a decidere il destino della battaglia.
Quando, come in questo caso, il tema centrale è di tipo “ecologico”, le motivazioni tecniche cominciano a moltiplicarsi e ogni parte ne enuncia alcune di ricorrenti: l’amministrazione parla della necessità di certi interventi che permettono di tenere insieme lo sviluppo della città e una logica ecologica “di scala” (p.e. ridurre le emissioni sul lungo periodo); chi difende il parco parla della necessità di rallentare o fermare il cosiddetto sviluppo, concentrandosi sulla dannosità locale della cementificazione e della riduzione del verde, nonché sulle contraddizioni dell’altra parte. Se la diatriba va avanti, ciascuna delle due parti metterà in campo degli “esperti” che forniscano autorevolezza.
Così al parco vari attori (comitati, associazioni, partiti…) hanno provato a elaborare un tessuto retorico che, facendo leva sul sentire della cittadinanza, potesse mettere in crisi l’amministrazione. Presto questo ha creato degli effetti collaterali sulla gestione del parco e della mobilitazione: la questione su cui mancava un accordo era quella di dove dirigere le energie, su che tipo di iniziative. La parte più “dialettica” della mobilitazione voleva investire in momenti comunicativi che interpellassero il sindaco e l’amministrazione, manifestazioni rumorose, più avanti partecipazione ai tavoli di confronto. La parte più “spontanea” si concentrava sulla presenza al parco, sulla vita in quella situazione.
Certo in qualche misura entrambe le posture sono state necessarie per il successo finale, perché il parco non sarebbe sopravvissuto se non fosse diventato una comunità, ma nemmeno se non avesse avuto una relazione col suo esterno. Però siamo chiari: è solo rifiutandoci di tenere un piano dialettico esteso e costante che siamo stati in grado di indebolire l’amministrazione e i suoi metodi “concertativi”. E grazie alla continuità della presenza al parco. Invece, l’istinto dell’associazionismo e della sinistra “di base” avrebbe (se non fosse stato arginato) fatto fallire l’esperienza Don Bosco. L’argomentazione più forte di quello che sostengo si è potuta vedere nei momenti di tensione, crisi e debolezza, cioè subito dopo i due grossi scontri con la polizia del 3 aprile e 20 giugno.
Nel primo caso (3 aprile) il parco viveva un momento di forza, e la contemporanea attivazione dei liceali dopo il pestaggio di Gio sembrava suggerire una possibile espansione della mobilitazione su altri temi (non solo l’ecologismo) e ad altre componenti (i giovanissimi, altri abitanti del quartiere raramente intercettati, …). In quei giorni però abbiamo visto un irrigidimento netto di Comitato, associazioni e partiti, che hanno mal digerito che si uscisse dalla griglia retorica precedente (la semplice difesa del verde) e non hanno mai gradito che il parco diventasse casa di altre persone oltre a quelle che avevano cominciato la lotta. Parliamo anche di personale politico o delle persone più esperte, che in passato hanno fatto parte di movimenti organizzati: queste persone avevano in mente – con più o meno buonafede – uno schema troppo rigido per accogliere la potenza che c’era in quella situazione. Non sono però stati in grado di arginare la vita reale del parco. Gli inviti a togliere le barricate sono caduti nel vuoto e la scelta di partecipare ai tavoli di confronto col Comune non si è affermata come scelta condivisa, ma solo come scelta di una parte delle persone mobilitate.
Nel secondo caso (20 giugno) il parco si è trovato in grande debolezza. La difesa del terrapieno nord era fallita e varie persone avevano rischiato di subire danni fisici. In questo momento, le persone che avevano portato avanti la strategia della dialettica pubblica si sono trovate nella necessità di giocare la parte delle vittime, perché quello era l’unico spazio rimasto nel gioco delle dichiarazioni sui giornali. Si poteva scegliere se essere vittime dei “radicali” che tenevano il parco e facevano le scritte contro gli assessori (come ha fatto Legambiente) oppure vittime della polizia. Il Comitato Besta ha scelto questa seconda strada, anche se la debolezza in cui si erano messi giocando la carta della comunicazione pubblica a oltranza ha portato a vari scivoloni anche dei suoi esponenti più esperti.
Anche la parte “movimentista” nelle sue versioni più radicali è stata troppo dipendente dalla sua auto-rappresentazione pubblica. In particolare nel momento di debolezza che ha seguito il 20 giugno, ci si è rifugiati nella propria immagine di radicali e si è accettato implicitamente il proprio ruolo di sconfitti, anche se con una postura più rabbiosa e “antirepressiva”. Su questo punto tornerò meglio più avanti.
Nonostante tutto il parco ha una propria vita, l’ha arricchita nei mesi di lotta in un modo che non era più contenibile nemmeno dalla contrapposizione tra mediatori e radicali.
Nei giorni di maggior tristezza collettiva, al donbosco hanno continuato a circolare persone, a trovarsi lì per chiacchierare, mangiare, dormire. Quando non c’erano le persone “della prima ora”, c’erano altre persone del quartiere oppure persone senza dimora che hanno dormito e mangiato lì. Ci sono stati giorni in cui il parco era tenuto e fatto vivere dai “senza casa”.
Il parco ha continuato a esistere e ha rifiutato di recitare la propria parte di sconfitto: in alcuni giorni di particolare demoralizzazione collettiva, una strategia comunicativa era stata proposta, che rendesse pubbliche le debolezze e le ferite accusate dopo il 20 giugno, che ne facesse un oggetto di discorso, di condivisione e di politica… oggi possiamo dire con certezza che niente sarebbe stato più sbagliato.
Anche quando noi, la parte più “militante” del parco, avvertivamo la debolezza, anche in quel momento, la vera vita del parco è rimasta opaca, illeggibile ma attiva: come avrebbe agito tutta questa folla a un nuovo tentativo di sgombero? Quante persone erano ormai abituate all’idea di un parco sempre presente e vivo? Quante persone si erano definitivamente convinte che il parco doveva restare? Nessuno aveva la risposta a questa domanda. Non ce l’aveva la questura, né il comune… per fortuna non ce l’avevamo nemmeno noi.
Il parco e la polizia
L’ingovernabilità del parco è stata evidente in particolare nei momenti di intervento violento delle forze dell’ordine, quando la piazza ha risposto in maniera disordinata e proprio per questo molto poco controllabile. In quei momenti (oltre che nelle giornate invernali in cui il presidio veniva effettivamente inventato dal nulla) si è osservata una fantasia coraggiosa.
Quello che intendo con “vita del parco” oppure quando parlo della comunità (opaca) che gravitava attorno al parco e alla battaglia per difenderlo, può risultare vago. Però è il fulcro di quello che è successo e vale la pena approfondirlo: il Don Bosco è interessante perché questa dimensione si è installata in un posto fisico, e in questo io trovo qualcosa che non solo propone delle soluzioni tattiche vincenti (come si è poi visto) ma anche qualcosa che al livello esistenziale è più desiderabile rispetto a ogni visione performativa dello spazio politico.
In entrambi i casi di intervento della poliza, alle manifestazioni in difesa del parco hanno partecipato non solo persone esperte, non solo persone che si erano già confrontate con lo scontro fisico. Quindi non solo persone che rischiavano di ripetere anche nello scontro una rappresentazione rituale.
C’erano persone che si trovavano per la prima volta in situazioni così ad alta tensione, dei giovani o giovanissimi in molti casi, ma anche persone più anziane da cui ci saremmo ragionevolmente aspettati che si allontanassero. Al contrario in tantissimi sono rimasti, in tantissimi hanno assunto una postura offensiva, in tantissimi hanno pensato e fatto qualcosa di tatticamente irragionevole, ma l’hanno fatto vedendo che questa irragionevolezza non cadeva nel vuoto: momento dopo momento le irragionevolezze si sommavano e creavano un terreno del tutto sfavorevole per la polizia e per gli operai chiamati a intervenire. Ogni avanzamento dei plotoni si trasformava nello sguarnimento di un pezzo di recinzione attorno a cui si trovavano dei manifestanti, creando un potenziale accerchiamento. La confusione generalizzata aumentava, non si riduceva nemmeno quando i manganelli hanno cominciato a frullare. Un operaio taglia un albero in tutta fretta, l’assenza di misure di sicurezza si materializza in un fusto enorme che rischia di spaccare la testa di un agente della Digos.
Quando alcune persone saltano per l’ennesima volta le recinzioni, la situazione non è più controllabile.
È interessante che un radicamento così profondo, fisico e testardo in un luogo, sia avvenuto su una vertenza abbastanza limitata quando a Bologna non mancano i “grandi temi” (cittadini e non) su cui mobilitarsi. Molte persone navigate dei movimenti e dell’associazionismo hanno vissuto questa cosa come una contraddizione da risolvere (con convergenze e rivendicazioni generaliste), ma forse si tratta di un elemento da indagare, come se avessimo colto un limite dell’esperienza della politica-di-movimento e un suo oltrepassamento momentaneo.
Anche il 20 giugno, in un contesto molto più sfavorevole, a folate varie persone si riavvicinano a una squadra di celerini furiosi. Assistiamo a scene di rabbia da persone che reputavamo calme e pacate. La polizia è costretta a usare le maniere fortissime, a far colare ancora il sangue, in un giorno che pensava di “normale amministrazione”, in cui al massimo ci sarebbe stato da strattonare qualche anarchico.
Nei giorni successivi a questa prova di forza, si stringe il cerchio “emergenziale”, il discorso dell’amministrazione cambia in modo rapido e il messaggio sui media è che il gioco sia durato fin troppo. Le urla che indicano i “facinorosi” e le “violenze dei No Besta” si moltiplicano, così come le assemblee in cui ci troviamo a discutere di facezie, di una scritta sul muro, dell’indignazione di questo o quel circolo opinionistico per le scelte lessicali di non si sa chi.
Mesi di equilibri tra diverse “anime” e “stili” sembrano cedere. Ma il dato che ha mandato in allarme la questura e il Comune è che il parco non si svuota: nonostante tutti gli scazzi, quel luogo ha assunto un valore che è impermeabile alle polemiche. Sto sintetizzando nella parola “polemiche” quel brusìo e insieme di discorsi rancorosi tipico, che accompagna sempre la dicotomia moderati-radicali.
Voglio ribadire che il parco ha schivato la fase polemista dopo il 20 giugno nonostante la presenza dei “radicali” e non grazie a loro: la parte movimentista-radicale del parco in questa fase (quasi sempre) tornava spontaneamente a rappresentarsi come (appunto) radicale, a rivendicare la propria purezza di fronte a un Comitato Besta che stava cedendo. Nascondendo dietro questa purezza i propri errori tattici o le proprie mancanze strategiche (o semplicemente la stanchezza per una lotta che ti mette alla prova anche al livello fisico e mentale).
La comparsa di queste “correnti” non ha però fermato gli eventi al parco, le colazioni all’alba, le tende, i pranzi collettivi: la vita del parco ha continuato a scorrere come un fiume indifferente ai diverbi tra i pesci.
Intermezzo sull’agire “militante” al Don Bosco
L’ “abilità militante” in questa situazione è stata l’individuazione della situazione, e il fatto di prodigarsi per mantenere un livello di comunicazione non rappresentativa, non cedere mai alla tentazione della sintesi discorsiva o della creazione di convergenze di facciata, che più che inutili, quando ci sono state, si sono rilevate dannose.
In questo paragrafo dirò molte volte “noi” riferendomi a quello zoccolo militante, proveniente da aree disomogenee che si riconoscono più o meno in un’attitudine anarchica o anarco-comunista. Quello zoccolo più giovanile che ha portato sul parco la grammatica antipoliziesca, i riferimenti alle ZAD, le tecniche di resistenza arborea e il dizionario libertario.
L’ipotesi che dobbiamo affrontare con estrema serietà è che i “nostri” meriti in questa vittoria siano pochi. La cosa che ci è riuscita, è fare in modo che nessuno canalizzasse l’energia del Don Bosco dentro uno dei tipici teatrini rappresentativi bolognesi, in cui la forza del momento viene subito funzionalizzata a qualcos’altro, alla “costruzione della cittadinanza” o “del movimento” (o del popolo, o dell’alternativa, o dell’autonomia, o della convergenza… a seconda del vocabolario a cui si fa riferimento).
Questo è avvenuto soprattutto grazie a gesti che hanno superato le persone stesse che li avevano concepiti: le casette, il modo di stare di fronte alla polizia, il presidio permanente. Una volta innescata la possibilità della “vita nel parco”, era impossibile controllarla, le persone hanno cominciato a fare lo stesso, superandoci. Accogliere questi imprevisti è stata l’intuizione migliore.
Nonostante tutto, però, al parco è mancata una strategia. Lo si è visto quando la mobilitazione poteva diventare più grande, coinvolgere altri pezzi di città: non c’è stata né capacità né voglia di incontrare queste diverse opzioni, di lanciarsi fuori dal perimetro del quartiere S. Donato. Il parco era diventato una comfort-zone mentale, soddisfaceva un bisogno di riconoscimento e non ha nutrito nessun pensiero strategico, nessuna vera novità (la ZAD, il diritto alla città, la lotta alla repressione… erano cose già viste, ed erano tutte enunciate come “principi etici”)
Nonostante la noiosa retorica dell’allargamento vertenziale (“non facciamo questo solo per un parco” “questa lotta non è solo per il verde”), la parte militante ha mancato l’appuntamento, in particolare quando l’arresto di Gio poteva smuovere la situazione e generalizzarla. Proprio quando uno spazio d’azione più largo si è proposto davanti a noi, nessuno ha allungato il passo, anzi abbiamo esitato.
La ricchezza dell’evento-Don-Bosco risiede nel rifiuto non-militante, pre-politico, emotivo contingente e diffuso del progetto-Besta. Un rifiuto che ci ha galvanizzato e che abbiamo condiviso senza pensarci due volte. Questa contingenza è stata la base su cui costruire la vittoria del Don Bosco nonostante le nostre debolezze politiche, e solo se affrontiamo questo punto a viso aperto – senza mentirci sulle nostre effettive forze e motivazioni – potremo eventualmente (se lo vogliamo davvero e lo riteniamo davvero possibile) sviluppare un piano strategico più largo, più esteso.
Individuare i rapporti di forza contingenti, per esempio, significa capire che l’ecologia ha un contenuto sostanziale quando si lega a un territorio, nel gergo movimentista la vediamo invece utilizzata d’abitudine per aggiornare il vocabolario “sociale”. O peggio, come ricettario tecnico per migliorare l’amministrazione del territorio.
Bisogna rilevare, poi, che la comunità-del-parco non è sopravvissuta alla vittoria. Questo non significa che quella comunità non sia ancora “qualcosa”, ma il problema sta proprio qui: appena terminato il parco, sono cominciate le parole per spiegarsi cos’è stato il parco, riportandolo dentro una logica-etica-pratica “di movimento”. Il parco è diventato un simbolo di radicalità, come se la vittoria fosse il risultato di una direzione politica.
Il problema sembra essere che il vocabolario “politico” tradisce sempre i bisogni e i desideri da cui è generato, trasformando ormai tutto in una indicazione etica generica senza sostanza.
Gli incontri del parco
La pluralità è sempre sulla bocca di tutti come una qualità e un punto di partenza delle situazioni politiche, in particolare quelle situazioni che criticano il modello urbanistico della città… Ma oltre questa ovvietà – che eravamo tanti e diversi, per generazione, estrazione sociale e abitudini politiche – c’è da andare più a fondo e capire cosa sia questa molteplicità, come ci sia o non ci sia stata composizione tra le tante anime, che cosa questo abbia portato di traducibile o intraducibile.
Le tipologie di persone al parco erano distanti per abitudini politiche, comunitarie, e anche in fondo avevano motivi diversi per stare in quel luogo. Sul parco non sono nate ipotesi forti rispetto a come trasformare questa differenza in una potenza politica duratura, e però l’incontro è avvenuto. Qui voglio soffermarmi sulla differenza che passa tra le “piattaforme di convergenza” e gli incontri veritieri: le prime sono rituali permanenti che accolgono la diversità quando si esprime in una lingua chiara e all’interno di una progettualità comune; invece gli incontri veritieri corrono sempre il rischio di scomparire, ma accolgono la diversità come negoziazione immediata a partire da una contingenza comune (un obiettivo e/o un affetto).
Certo, dentro ogni “convergenza” o “piattaforma politica” devono prodursi degli incontri veritieri, ma voglio soffermarmi sul fatto che la politica rappresentativa-convergente per come è concepita nella Sinistra (il Movimento, il Diritto alla Città, la GKN, ecc.), sconfessa la priorità degli incontri, rileggendoli sempre attraverso una lente “sociale” e quindi una finalità “più alta”. Il movimento che abbiamo valorizzato al Don Bosco è precisamente inverso: la finalità è scaturita dall’immediatezza, senza mai farsi piattaforma, e proprio per questo non ha bruciato tutta la sua potenza politica.
Vale la pena fare una considerazione più generale su questo: i paradigmi rivoluzionari-radicali sono in crisi da un po’, e di fatto i vari movimenti politici che hanno ereditato le tradizioni radicali si trovano a riproporre dei linguaggi svuotati. Il mantenimento prolungato di questi linguaggi avviene concretamente aggirando il problema della strategia (e del senso della vittoria) e riducendo le situazioni a una successione continua di tattiche da inanellare senza posa. Il mazzo delle possibilità è arci-conosciuto: la piattaforma (cittadina, locale, nazionale), la manifestazione, il comunicato, la forzatura dialettica o di piazza, l’interpellazione diretta dell’amministrazione, la proposta di una alternativa, e qualche altro che sto dimenticando. Se ci si interroga sulla strategia più sostanziale ci si troverà di fronte a alcune prospettive assolutamente deboli: spazi elettoralisti, la costruzione di posizionamenti radicali puramente etici, o le varie forme democratiche partecipative “dal basso”.
Insomma, la foga con cui si corre a (ri)proporre la propria tattica, maschera a stento che un pensiero strategico radicale (o anche solo che non sia rassegnato a com-partecipare all’amministrazione pubblica) è oggi assente.
Quello che sto dicendo rischia di suonare astratto, perché la costruzione di grammatiche condivise per fare propaganda, per massificare il proprio punto di vista, richiede sempre di generalizzare quello che si sta dicendo, estraendolo dalla sua estrema singolarità. Il punto che voglio sottolineare è la necessità di non tradire la precedenza di questo tratto singolare, di queste negoziazioni contingenti. Può suonare come una pretesa idealista, ma invece è l’esatto contrario perché in assenza di un piano strategico, la priorità del piano d’immanenza degli incontri non è solo un’esigenza individuale (di ri-connessione con un senso afferrabile dell’agire) ma anche l’unica prospettiva che permette di porsi seriamente la questione di cosa non ci piace davvero del presente.
Di più: gli spazi per la negoziazione dal basso sono sempre più ristretti. Ormai il teatro della partecipazione è diventato un format per professionisti esperti, che lascia ben pochi spazi di negoziazione reale. Ogni comitato, gruppo di cittadini, gruppo politico, dovrebbe rendersi conto che non esiste un rapporto di forze per imporre nemmeno piccoli avanzamenti con strumenti “partecipativi”.
Qualche anarco-matto senza un vero piano strategico è riuscito a imporre la fine di un progetto, quando i macchiavellismi da 4 soldi dell’associazionismo legato al PD (Dalla lista della vicesindaca alla sezione bolognese di Legambiente) non è riuscito a ottenere nemmeno un impegno sul conteggio degli alberi. A Bologna in particolare, piegarsi al dibattito “partecipativo” paga soltanto se si passa dalla Fondazione Innovazione Urbana (e si comincia a fare un po’ di lavoro gratuito per loro) cioè da una filiera rodata di valorizzazione di saperi e capitali. In questo senso appare logica la scelta dell’area “ex-disobbediente” di parassitare i progetti dell’assessore Laudani (certo, in un’ottica del tutto “succube” all’amministrazione, ma su questo non mi dilungo in questo testo).
Altre considerazioni sulla composizione della protesta
Le persone che hanno cominciato a sollevare il problema del Don Bosco (e che sono rimaste l’anima fondamentale della mobilitazione) sono abitanti oltre i 55 anni, che frequentano spesso il parco. Sono per lo più educatori, alcuni insegnanti delle scuole Besta, bolognesi di nascita o da moltissimi anni. La maggior parte di loro ha probabilmente votato quasi sempre PD o a sinistra del PD, ma non erano poche le persone mosse da una critica aspra della sinistra e che portavano grammatiche differenti, più “grilline” o “leghiste”.
Con una schematizzazione veloce, da discorso giornalistico, possiamo dire che sul tema della critica al modello urbano, a Bologna esista una corrente critica “da sinistra” che ricerca l’interlocuzione con Coalizione Civica e l’ala sinistra del PD, e una corrente critica “da destra” che ha avuto come bersagli privilegiati il progetto del tram e soprattutto l’organizzazione della “zona 30” in periferia bolognese, con i nuovi limiti di velocità per le macchine (ed ha trovato sponda in particolare nella Lega). Al parco Don Bosco, e in particolare nel Comitato Besta, la corrente maggioritaria era quella “di sinistra” in questo schema.
La schematizzazione giornalistica però ha mostrato tutti i suoi limiti, in particolare nel contesto del Don Bosco. Se si andava oltre i personaggi più politicizzati – quelli che erano passati già per i centri sociali o per l’associazionismo più politicizzato – si poteva notare che c’era una circolazione di discorsi molto agevole e chiara tra tutte le anime della protesta, che aveva nella conservazione di flora e fauna il suo pivot. Il tema della “zona 30”, per come si ripresentava nelle chiacchiere, sfidava tutte le categorizzazioni dozzinali ma molto nette che siamo abituati a vedere nel dibattito sclerotizzato sui social (che la pandemia ha portato a estremizzazioni grottesche): da una parte i ragionevoli che credono nel cambiamento climatico e dall’altra i negazionisti beoti. In realtà una misura “ragionevole” come zona30 era stigmatizzata o ridicolizzata da tutti (sto tralasciando per ora la parte giovanile più militante), e questo nonostante la conservazione del verde e il fastidio verso l’automobile fossero argomenti del tutto condivisi.
Anche sulla questione vera e propria del cambiamento climatico, non è facile capire come la pensassero tutti i partecipanti alle varie situazioni, di sicuro sulle chat collettive abbiamo visto che la prossimità con ambienti dalle posizioni cosiddette “complottiste” non era marginale.
Nonostante la componente giovanile fosse invece ben più “rigida” sulle questioni ideologico-retoriche legate all’ambientalismo, non si è mai prodotta una vera e propria discussione su questi temi, e quindi il tema ambientale è stato trattato solo dalla sua prossimità, attraverso la questione della salvaguardia degli alberi, senza fare delle questioni tecnico-scientifiche un punto dirimente se non più avanti nella mobilitazione.
Vale la pena qui muovere una critica netta alla posizione di Wu Ming 1, che ormai da tempo mette in guardia contro il proliferare della mentalità complottista, in particolare sul tema ambientale. Non solo nel caso del Don Bosco è stato importante interrompere il questionamento su “cosa fosse vero al livello scientifico”, per lasciare tutto lo spazio possibile ai naturali sospetti e alle loro libere associazioni; ma in più, quando si è tornati su un piano più tecnicizzato-scientifico del discorso, abbiamo potuto vedere l’assoluta affinità (e in fondo anche la comune debolezza) tra la scienza-strumentale al discorso politico della sinistra, e il modo di teorizzare complottista che Wu Ming 1 ritiene più proprio della destra. Non stiamo dicendo che le due tendenze siano del tutto identiche, ma vogliamo individuare alcuni elementi di affinità molto marcata che rendono inefficace la distinzione tra queste due attitudini. In fondo “la Q di complotto” (il libro che sto prendendo a riferimento per criticare questi argomenti) si riduce a un incredibile sforzo nominalista che aggira la sostanza dei dibattiti vivi in quest’epoca.
Se da una parte il fenomeno chiamato “complottismo” si concentra sulle teorie accettate della governance per ribaltarle in contro-teorie negative, nell’altro campo (la “sinistra”, la parte ragionevole) abbiamo la riproposizione di “teorizzazioni dal basso” che soddisfano dei posizionamenti politici, e quindi mettono in secondo piano il rigore metodologico in nome appunto di un posizionamento. Quest’ultimo in particolare è un gesto ricco di valore politico per chi scrive, quindi non gli muovo qui una critica, ma voglio sottolineare che non è poi così diverso dal primo gesto, quello denominato “complottista”. Soprattutto perché quello che avviene concretamente è che si ricerca in grande fretta l’esperto più adatto al proprio discorso, e si marginalizzano tutti gli approfondimenti tecnico-disciplinari, spesso densi di risvolti politici, epistemologici, filosofici.
Se da una parte (complottisti) si mette l’accento sulla connivenza del discorso scientifico con le malefatte degli amministratori, dall’altra si presume sempre che ogni posizione tecnico-scientifica assunta dal potere sia espressione diretta di un interesse esterno al campo scientifico (e quindi economico o politico). Anche qui la distinzione tra i due approcci è tutt’altro che profonda, e denota semmai una evoluzione nelle grammatiche dell’epoca in cui però è possibile trovare molta continuità anche con la storia dei movimenti.
È interessante infine che entrambi gli approcci – o sarebbe meglio dire entrambi gli stili del discorso – si sono arenati su una comune debolezza: le intuizioni che illuminano la critica e permettono di creare legami, vengono a un certo punto della battaglia sistematizzate in un discorso generale, in una verità globale. Si tratta del momento in cui il bisogno di legittimità simbolica (agli occhi dell’amministrazione, agli occhi del “pubblico”) diventa un fattore di auto-contenimento della protesta. C’è sempre un motivo ragionevole per farlo (rendersi più chiari, aumentare il bacino dei consensi, rendere possibile una trattativa…), ma nella maggior parte dei casi il dispositivo “dialettico” comincia a fagocitare la protesta stessa. Lo “stile di sinistra” comincia a costruire piattaforme, progetti di “alternative”, proposte “dal basso”; lo stile “complottista” comincia a trasformare le proprie intuizioni sul potere in sistemi di verità speculari e contrari alla verità del potere, e anch’esso legittima cordate dentro organi rappresentativi (vedi il caso della Consulta del Verde bolognese e le “associazioni dissidenti”).
Al parco Don Bosco, in particolare, la costruzione di una autorevolezza scientifica è diventato l’assillo, l’arma che il Comitato Besta pensava di poter utilizzare per vincere la battaglia. Il dispositivo-scienza-ecologia ha in breve cominciato a funzionare come una macchina oggettivante: si cercavano gli esperti in grado di affermare la verità scientifica di quello che già rivendicavamo, come se un botanico desse più verità alla necessità di mantenere vivo il parco, una necessità che stavamo già affermando e prendendo in carico.
Le energie spese per rendersi legittimi agli occhi dell’amministrazione e del pubblico hanno avuto conseguenze dirette nell’organizzazione della protesta, affaticandola. Ma su un piano più teorico è soprattutto interessante che lo schema utilizzato sarebbe attaccabile dagli strumenti della critica al complottismo, proprio quella critica che WM1 e altri pensano di poter utilizzare per distinguere un modo opportuno di far politica dal modo complottista: di fatto l’organizzazione dei convegni ha cercato l’esperto più adatto a quello che si voleva dire, senza approfondire le prese di posizione scientifico-epistemologiche degli esperti considerati, ma proprio considerandoli come “enunciatori di verità”. Come mai questi esperti dicono una cosa se gli esperti del Comune di Bologna ne dicono un’altra? Questa domanda non interessava.
Questo è il classico esempio di cherry-picking, uno di quei bias da manuale di cui sono piene le critiche dei debunker. È del tutto probabile che nei corridoi di palazzo d’Accursio si parlasse dei convegni del Comitato Besta come di un ritrovo di ciarlatani, perché in effetti si sono utilizzate forme di presentazione “scientifica” del proprio pensiero senza precisare mai i posizionamenti etico-politici non-oggettivi da cui si partiva. I “toni da guru” di certi interventi, rientrano appieno in una logica ed una estetica che la stessa sinistra di base chiamerebbe “complottista” se non fosse che questa protesta era “dalla nostra parte”. Per fortuna tutto questo è passato in sordina, fino a essere risollevato in questo testo per trarne indicazioni più generali.
Il desiderio – o forse sarebbe meglio dire il bisogno – di una legittimazione simbolica sembra mettere in secondo piano la contingenza del problema, e anche la possibilità di una vittoria immediata.
Questa lotta evidenzia quindi un irrisolto legato a doppio filo con questo tempo, qualcosa che non riguarda solo la questione dell’autorevolezza dialettica, ma della (auto)rappresentazione tout court: dei moderati e dei radicali, dei complottisti identitari e degli anarchici. Come se attorno alla questione della legittimazione e della riconoscibilità si giocasse qualcosa di più importante sia dei sistemi etici che delle vittorie singolari.